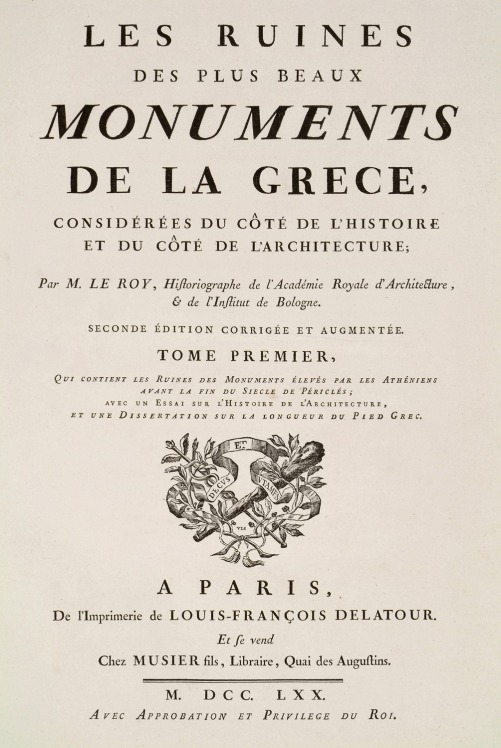Di Paola Mangano
La voce Pittore dell’Encyclopédie, redatta dal Cavaliere Louis de Jaucourt (*),
è rintracciabile nel volume dodicesimo della seconda edizione (1769),
nella versione originale francese on line seguendo il link che riporto
di seguito – Byterfly. alle pagine 203 e 204.
Anche
se l’attenzione degli enciclopedisti era rivolta da una parte alle
tecnologie e dall’altra ad argomenti filosofici, politico-religiosi e
scientifici – sui quali è oggi reperibile una abbondante e qualificata
saggistica – esiste un notevole numero di voci, non ancora
sufficientemente studiate, che riguardano le cosiddette belle arti.
L’arte
nell’Encyclopédie, recuperando la sua originaria dimensione tecnica,
diviene fenomeno pienamente legato alla sfera del lavoro e dell’utilità
sociale, estrinsecabile in una molteplicità di pratiche, finalizzata
all’incremento ed alla diffusione della cultura nella società.
In
tutta la mole delle voci artistiche mi concentrerò su quelle che più
interessano la pittura al fine di trarne qualche spunto di riflessione,
lungi da me e dalle mie competenze proporre un’analisi critica
autorevole.
Pittore
Artista che sa rappresentare ogni sorta di oggetti per mezzo di colori e pennello.
La
fortuna di un pittore è di essere nato dotato di genio. (1) Questo
genio è quel senso che eleva i pittori al di sopra di loro stessi, che
permette loro di immettere l’anima nelle immagini e il movimento nelle
composizioni che rappresentano. L’esperienza prova a sufficienza che non
tutti nascono col genio che permette di diventare pittori. Abbiamo
visto uomini di spirito, che avevano copiato parecchie volte ciò che la
natura ha prodotto di più piacevole, invecchiare col pennello e la
tavolozza in mano, senza elevarsi al di sopra del rango di mediocri
coloristi e servili copiatori di rappresentazioni altrui. Gli spiriti
più comuni sono capaci di essere pittori, ma mai grandi pittori.
Per i
pittori non è sufficiente avere del genio, concepire idee nobili,
immaginare le composizioni più eleganti e trovare le espressioni più
patetiche: è anche necessario che la loro mano sia stata resa docile a
flettersi con precisione in cento maniere diverse, per diventare capaci
di tracciare con esattezza la linea che l’immaginazione richiede. Il
genio ha, per così dire, le braccia legate in un artista la cui mano non
sia sciolta. Quanto abbiamo detto per la mano, vale per l’occhio;
bisogna che l’occhio di un pittore sia presto abituato a giudicare con
un’operazione sicura e facile, al tempo stesso quale effetto debba fare
una figura di una certa altezza in un gruppo e quale effetto farà un
certo gruppo in un quadro, dopo che il quadro sarà dipinto. Se
l’immaginazione non ha a disposizione mano e occhio capaci di
assecondarla in ciò che richiede, dalle più belle idee generate da
questa immaginazione non può che risultare un quadro grossolano, che lo
stesso artista che lo ha dipinto rifiuterà, in quanto si renderà conto
che l’opera prodotta dalla propria mano è inferiore all’opera immaginata
dal suo spirito.
Lo studio necessario per perfezionare occhio e mano
non si fa dedicando qualche ora distratta a un lavoro spesso
interrotto. Tale studio richiede una totale attenzione e una
perseveranza che si protragga per molti anni. E’ nota la massima che
impedisce ai pittori di lasciar passare un intero giorno senza stendere
almeno qualche pennellata; non per niente si applica questa massima a
tutte le professioni, tanto la si è ritenuta saggia: nulla dies sine
linea. (2)
L’unico periodo della vita che è particolarmente adatto a
far acquisire perfezione all’occhio e alla mano è quel tempo in cui gli
organi, sia interni sia esterni, stanno completando la loro formazione: è
il periodo che va dai quindici ai trent’anni. Durante questi anni gli
organi contraggono facilmente tutte le abitudini, di cui la loro intima
conformazione li rende suscettibili. Ma se si perdono questi anni
preziosi, se si lascia che passino via senza trarne profitto, la
docilità degli organi svanisce irrimediabilmente e nessun sforzo può
essere fatto per rivitalizzarla. Sebbene la lingua sia un organo molto
più agile della mano, tuttavia, pronunceremo sempre male una lingua
straniera imparata dopo i 30 anni.
Un pittore deve essere conscio di
quale genere di pittura gli è proprio e limitarsi a questo genere.
Rimane confuso tra la folla chi invece potrebbe essere elevato al rango
degli illustri maestri, chi si è lasciato trascinare da una cieca
imitazione, che lo ha spinto a diventare abile in quei generi di pittura
per i quali non era nato e che gli hanno fatto trascurare quelli per i
quali invece era adatto. Le opere che ha tentato di fare sono, se si
vuole, di una classe superiore; ma non è forse meglio essere citati per
essere uno dei primi ritrattisti del proprio tempo, piuttosto che un
miserabile arrangiatore di figure ignobili e storpie?
I giovani
pittori che aspirano al successo devono ancora guardarsi dalle passioni
violente, in particolare l’impazienza, l’avventatezza, l’avversione.
Quelli che si trovano in cattiva situazione economica non disperino di
migliorare la propria situazione con l’applicazione; l’opulenza
allontana dal lavoro e dall’esercizio della mano, la fortuna nuoce più
al talento di quanto non possa essere utile; ma d’altra parte, in uno
Stato i meriti, gli onori, e le ricompense sono necessari per
incoraggiare lo sviluppo delle belle arti e per formarvi artisti
superiori. Un pittore in Grecia era un uomo celebre non appena meritava
di esserlo. Questo tipo di merito faceva di un uomo comune un
personaggio e lo eguagliava a ciò che c’era di più grande e d’importante
nello stato; i portici pubblici in cui i pittori esponevano i loro
quadri erano i luoghi dove gli uomini più illustri della Grecia si
recavano di volta in volta per esprimere il proprio giudizio. Le opere
dei grandi maestri non erano allora affatto considerate come oggetti
ordinari di arredamento, destinati ad abbellire gli appartamenti di un
privato, ma venivano reputate i gioielli dello Stato e un vero tesoro
pubblico, di cui tutti i cittadini dovevano gioire. Si paragoni dunque
l’alacrità che gli artisti di un tempo avevano nel perfezionare il
proprio talento con la brama che noi vediamo nei nostri contemporanei
nell’ammassare ricchezze, o nel fare qualche cosa di più elevato che li
agevoli ad arrivare ai grandi impieghi dello Stato.
Sebbene la
reputazione di un pittore dipenda maggiormente, che non quella dei
poeti, dall’approvazione degli esperti, tuttavia, questi non sono gli
unici giudici del loro merito. Nessuno di loro perverrebbe, se non molto
tempo dopo la morte, al meritato prestigio che gli è dovuto, se tale
giudizio spettasse agli altri pittori. Fortunatamente i suoi rivali
conterranei ne sono i maestri solo per un certo periodo. Il pubblico che
viene illuminato rivendica a poco a poco il giudizio al proprio
tribunale e rende a ciascuno quella giustizia che gli spetta. Ma in
particolare un pittore, che tratta grandi soggetti, che dipinge cupole e
volte di chiesa o che fa grandi quadri destinati a essere sistemati in
quei luoghi ove molti uomini sono soliti riunirsi, è più conosciuto per
quello che è, piuttosto che il pittore che lavora a quadri di cavalletto
destinati a essere chiusi in appartamenti privati.
Ci sono inoltre
luoghi, tempi e paesi in cui il merito di un pittore è riconosciuto più
che altrove. Per esempio i quadri esposti a Roma saranno maggiormente
apprezzati nel loro giusto valore, di quanto non lo sarebbero se fossero
esposti a Londra o a Parigi. Il gusto naturale dei Romani per la
pittura, le occasioni che essi hanno di gustarne, se così si può dire, i
loro costumi, la loro scarsa operosità, l’occasione che loro hanno di
vedere continuamente nelle chiese e nei palazzi capolavori di pittura, e
può anche darsi la sensibilità dei loro organi, rendono questa nazione
adatta più di ogni altra ad apprezzare il merito dei propri pittori
senza l’aiuto della gente del mestiere. Infine un pittore ha conseguito
una buona reputazione, quando le sue opere hanno assunto valore presso
gli stranieri; non è sufficiente avere un piccolo gruppo di gente che le
apprezzi, bisogna che siano comprate e ben pagate; ecco la pietra di
paragone del loro valore.
Ciò che talvolta impedisce il talento dei
pittori, dice al proposito Voltaire (3), e ciò che sembrerebbe spegnerlo
è il gusto accademico, è lo stile che i pittori traggono da coloro che
ne sono ritenuti i maggiori esponenti. Le accademie sono senza dubbio
molto utili per formare gli allievi, soprattutto quando i direttori
operano seguendo le norme del grand gout, ma se un direttore persegue il
petit gout, se il suo stile è secco e arido, se le sue figure fanno le
smorfie, se le sue espressioni sono insipide, se il suo colorito è
debole, gli allievi, soggiogati dall’imitazione, o per il desidero di
compiacere a un cattivo maestro, perdono completamente l’idea della
belle nature. Datemi un artista che sia totalmente preoccupato di
acquisire lo stile dei pittori suoi contemporanei, ne risulterà che ciò
che produce sarà compassato e forzato. Datemi un uomo dallo spirito
libero, pregno della belle nature che copia, ebbene quest’uomo riuscirà.
Quasi tutti gli artisti sublimi sono fioriti prima dell’istituzione
delle accademie, o hanno lavorato secondo un gusto diverso da quello che
vigeva in quelle società; quasi nessuna opera che viene definita
accademica ha ancora costituito, in alcun genere, un’opera di genio.
Il Cavaliere De Jaucourt
L’Encyclopedie, Tomo XII, pag. 203
La traduzione è tratta da Collezione
dell’Enciclopedia, L’Arte e l’Architettura a cura di Cinzia Maria Sicca e
Lucia Tongiorgi Tomasi, 1979 Gabriele Mazzocca Editore

La scena raffigura uno studio in cui si è cercato di riunire diversi tipi di pittura. Sullo sfondo dell’atelier si vedono due statue antiche, un globo, una squadra e alcuni libri, tutte cose utili ai pittori e che testimoniano lo studio dell’antichità, della storia, della geografia e dell’architettura.
La fig. 1. rappresenta un pittore di soggetti storici. a, Scaleo; b, bacile per lavare i pennelli o grande scatola per colori; c,macina di pietra per i colori.
La fig. 2. rappresenta un ritrattista. d, scatola dei colori.
La fig. 3. raffigura un pittore intento a eseguire una riduzione di un quadro del quale vuole fare una copia; e, quadro che gli serve a modello; f, tela sulla quale ha tracciato tanti quadrati quanti ne ha fatti su quello che si propone di ridurre (o di copiare).
La fig. 4. rappresenta un pittore di ritratti in miniatura.
Nella tavola in basso
Fig. 1. Poggiamano. 2. 3. e 4. Spatole di forme differenti. 5 e 6 Spazzolini di cui ci si serve per fondere i colori. 7. 8. e 9. Pennelli. 10. 11. e 12. Tavolozze di forme diverse
Per
eccellere nell’attività di pittore occorrono doti naturali,
acquisizione della tecnica e molta pratica quotidiana. Per gli
enciclopedisti l’insieme di questi fattori non possono che estendere i
limiti dell’arte portando l’artista tanto in alto da elevarsi da lui
stesso.
Genialità, tecnica ed esperienza quindi; tuttavia il genio
non sempre sa disciplinarsi ed adeguarsi alle regole anzi Kant individua
nel “Genio” quella facoltà, che hanno certi uomini privilegiati, di
dare la regola all’arte offrendola come esempio da seguire. Per questo
l’opera dell’artista che possiede il genio non è soltanto piacevole, ma
bella e paragonabile alla bellezza naturale, perché non sottostà a
regole, ma le crea.
Il genio è un puro dono della natura, e il suo
prodotto è il frutto di un momento ispirato; il gusto è il risultato di
un lungo studio, poggia sulla conoscenza di una quantità di regole
solidamente stabilite o supposte tali, produce opere di bellezza
meramente convenzionale. Le regole e le leggi del gusto sono di ostacolo
per il genio.
Un’apparente contraddizione pervade questo scritto.
Da una parte il genio deve imparare la tecnica e quindi sottostare a
regole ben precise di studio e dall’altra non ne deve tener conto perché
sarà lui stesso a crearne di nuove. Ma quello che in fondo si vuol dire
è che in un mondo ideale l’artista dotato di genio saprà appropriarsi
di tecniche e metodi per farne un uso proprio, come e dove non ha
importanza. Tuttavia, credo che con il passare del tempo questo concetto
di genio si sia trasformato in un escamotage per giustificare
qualsivoglia realizzazione pseudo-artistica.
Si chiede in questo
scritto al giovane pittore dal guardarsi dalle passioni violente che
possono nuocere al talento così come l’ambizione alla fama e alla
ricchezza; eppur, che io ricordi, sono più numerosi gli artisti
tormentati che quelli di pacato spirito e diventare famoso e ricco pare
sia l’aspirazione di ogni individuo di quella e di questa
contemporaneità.
Jaucourt riprende in questo articolo pressoché alla
lettera uno scritto volterriano del 1752 (nota n. 3), argomentazioni
molto prossime a quelle sostenute nella voce Talent delle Pensées da
Rousseau, sempre pronto a rifiutare ogni genuflessione nei confronti del
potere istituzionale a tutto vantaggio della natura: “Tante istituzioni
in favore delle arti non fanno che nuocere loro. Moltiplicando
impudentemente i soggetti si confondono; il vero merito resta soffocato
nella folla, e gli onori dovuti al più abile sono tutti per il più
intrigante.” J.-J. Rousseau, Les pensees de J.J. Rousseau, citoyen de
Geneve. Si esprime qui un concetto prettamente illuminista contro la
tradizionale pittura accademica, conservatrice e di maniera, dove non
c’è contatto tra l’artista e la realtà. Si radicalizza quindi lo scontro
tra il mondo accademico e lo stato moderno nascente, caratteristica non
secondaria dell’intera iniziativa editoriale dell’Encyclopédie – le cui
vicende travagliate sono un rilevante sintomo della difficoltà di
transizione fra “vecchio” e “nuovo” sapere.
Note:
*) Cavaliere Louis de Jaucourt (Paris,
Sept 27, 1704; Compiègne, Feb 3, 1779), fu il più prolifico tra gli
oltre 130 collaboratori dell’Encyclopédie. Ha studiato teologia a
Ginevra, scienze esatte e naturali a Cambridge, medicina a Leida, dove
ha incontrato Tronchin. Tornato a Parigi nel 1736, visse in una società
mondana e filosofica. Figura pressoché sconosciuta sebbene centrale per
l’Encyclopédie contribuendo con ben 17.000 articoli. Fu lui a coordinare
la redazione degli ultimi volumi e scrisse per loro più della metà
degli articoli, in un momento in cui D’Alembert aveva lasciato l’avventura e quando Diderot, notevolmente occupato sul lavoro delle tavole, aveva grande bisogno del suo sostegno.
1)
Il concetto di genio è presente nelle voci artistiche dell’Encyclopedie
con il significato di elemento vivificatore dell’imitazione della bella
natura che tuttavia non può prescindere da norme interne che lo
disciplinano. Ad esso è strettamente connesso il gusto.
2) La locuzione latina “Nulla dies sine linea”, tradotta letteralmente, significa nessun giorno senza una linea. (Plinio il Vecchio, Storia Nat., 35).
La frase è riferita al celebre pittore Apelle, che non lasciava passar
giorno senza tratteggiare col pennello qualche linea. Nel significato
comune vuole sottolineare la necessità dell’esercizio quotidiano per
raggiungere la perfezione e per progredire nel bene.
3) Voltaire nel Catalogue de la plus parts des ecrivains francais,
cit., dice “Alle volte i talenti dei pittori sono costretti proprio da
ciò che apparentemente dovrebbero svilupparli: il gusto accademico e la
maniera che i pittori seguono secondo il gusto di coloro che presiedono
alle accademie. Le accademie sono indubbiamente utili per formare il
gusto degli allievi, soprattutto quando i loro direttori lavorano
secondo il buon gusto. Ma se il maestro ha poco gusto, se la sua maniera
è arida o leziosa, se le sue figure sono scorrette, se i suoi quadri
sono dipinti come ventagli, gli allievi, soggiogati dall’imitazione o
dalla voglia di piacere a un cattivo maestro, perdono completamente
l’idea della bella natura. Sulle accademie pesa una fatalità: non si è
mai vista un’opera, detta accademica, in nessun genere, che sia un’opera
di genio. Se un artista è troppo preso dal timore di non impadronirsi
della maniera dei suoi confratelli, le sue produzioni saranno compassate
e forzate, ma se un uomo è di spirito intraprendente, pieno della
natura che imita, riuscirà. Quasi tutti gli artisti sublimi, o sono
fioriti prima delle fondazioni delle accademie o hanno lavorato secondo
un gusto diverso da quello che regnava in quella società.”
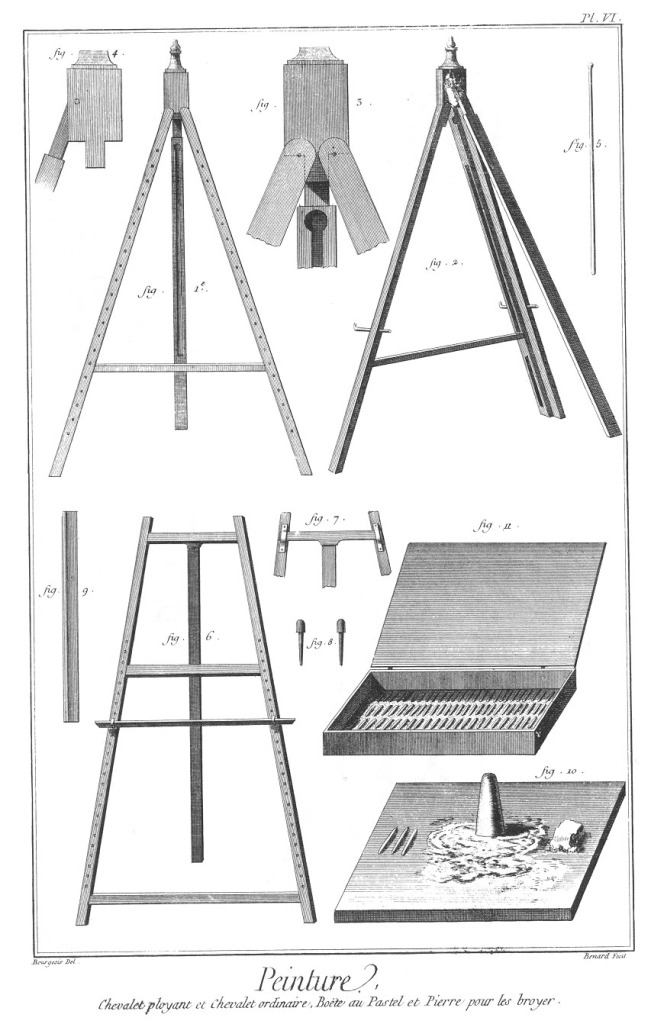
PITTURA - STORIA DELLE BELLE ARTI DA L'ENCYCLOPEDIE
fonte: PASSIONARTE


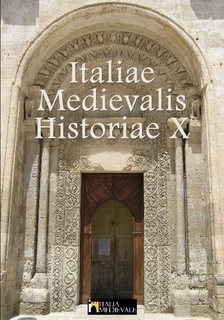
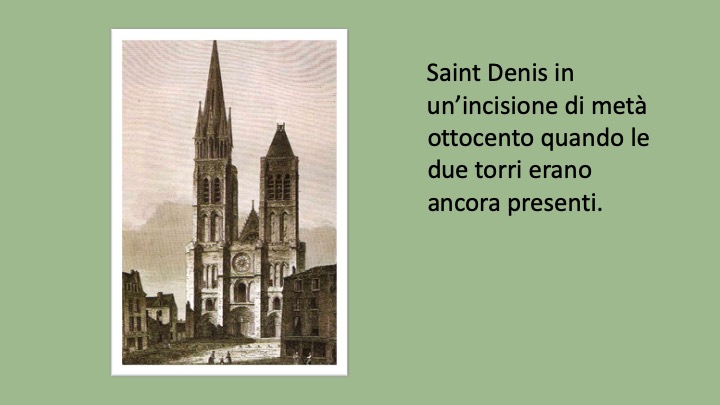

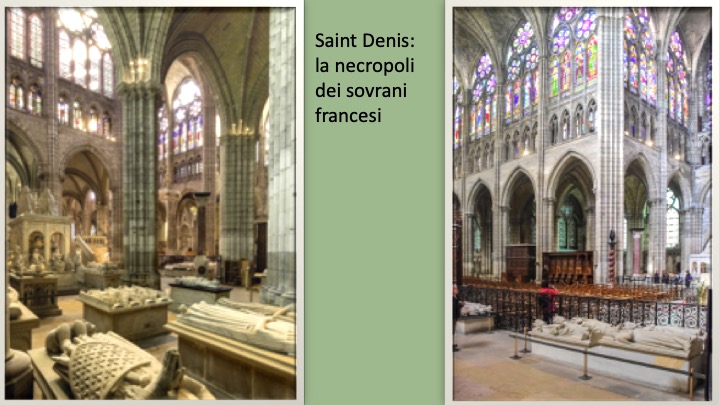
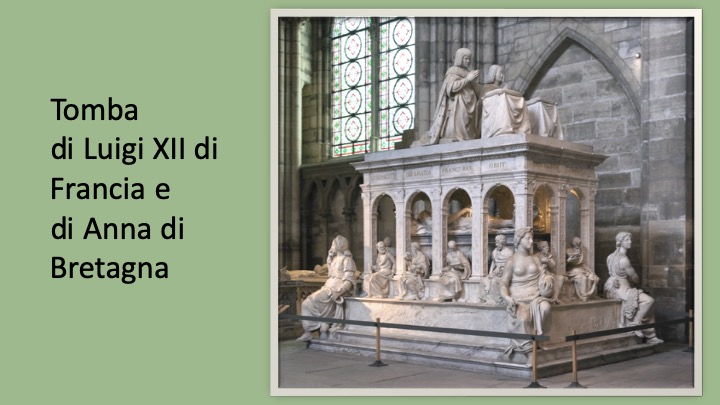
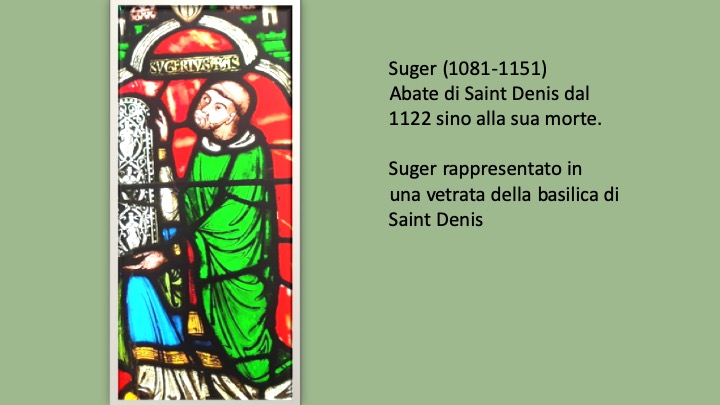

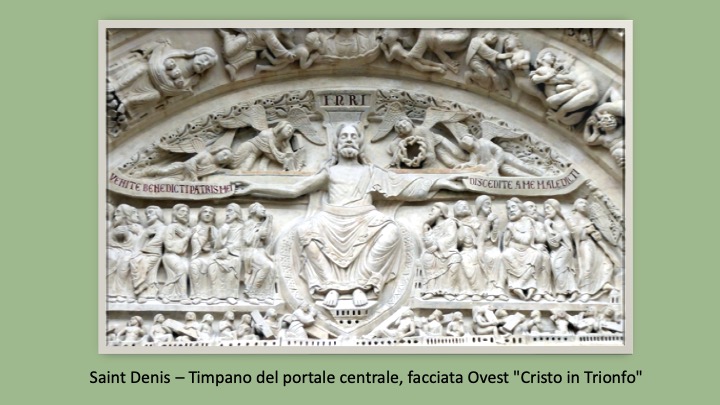
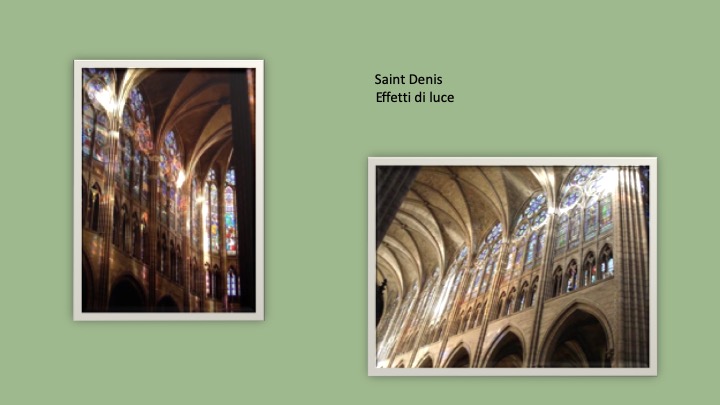
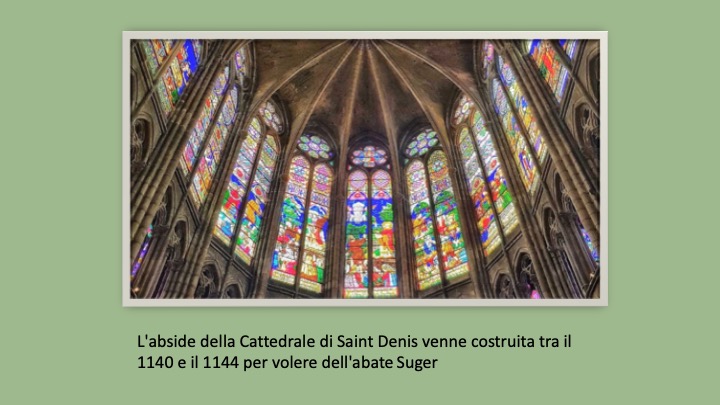
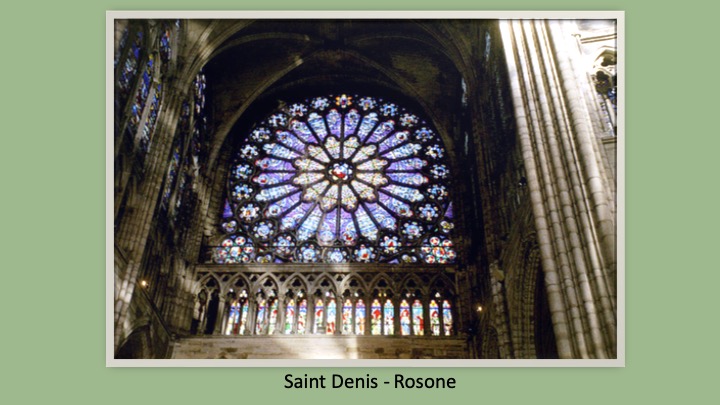
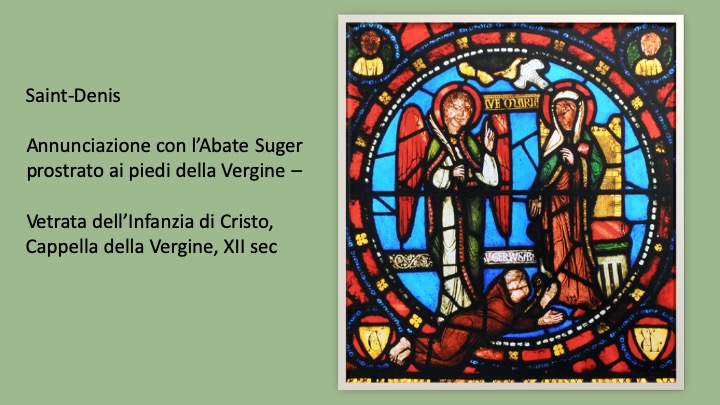
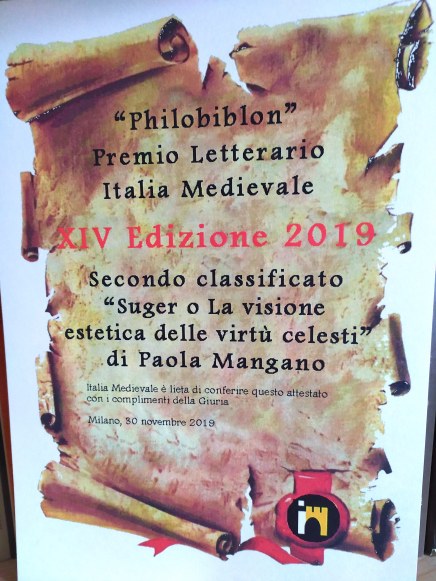


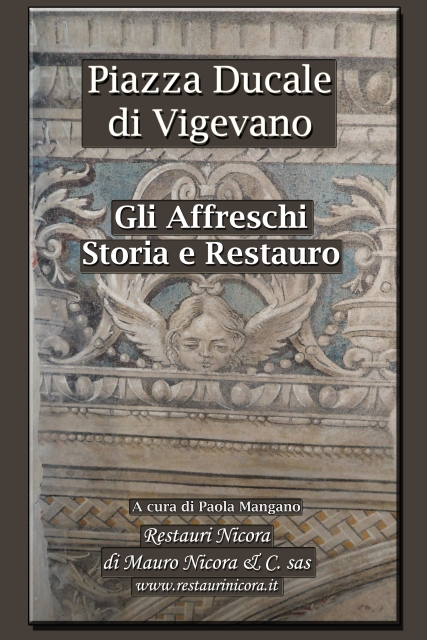




 James Stuart & Nicholas Revett ANTIQUITIES OF ATHENS 1762
James Stuart & Nicholas Revett ANTIQUITIES OF ATHENS 1762